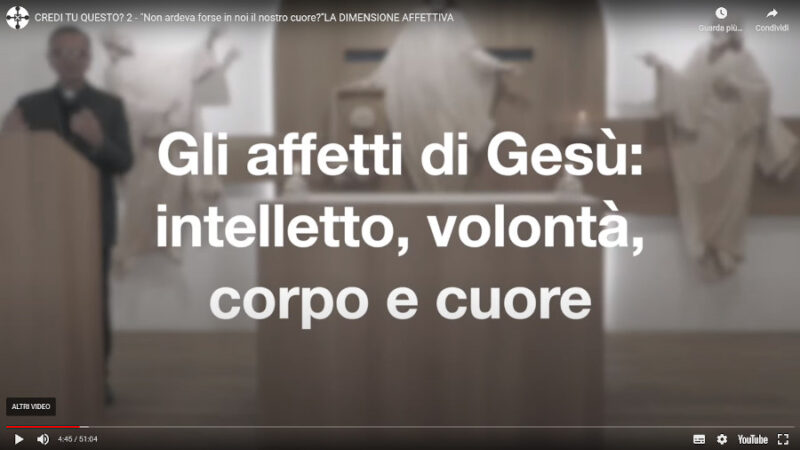Secondo incontro del percorso CREDI TU QUESTO?
LUNEDÌ 6 NOVEMBRE – “Non ardeva forse in noi il nostro cuore?” – LA DIMENSIONE AFFETTIVA
Scarica la catechesi del Vescovo –>
Questo contenuto non è disponibile per via delle tue sui cookie
CREDI TU QUESTO? 2° incontro
“Non ardeva forse in noi il nostro cuore?”
LA DIMENSIONE AFFETTIVA
6 novembre 2023
«La vita affettiva è dono Apriamoci alle relazioni»
Nel secondo incontro di “Credi tu questo?”, l’arcivescovo Erio Castellucci dedica la sua riflessione alla dimensione affettiva, vissuta da Gesù attraverso quattro emozioni primarie come la rabbia, la paura, il dolore e la gioia che percorrono i Vangeli. Gesù ha manifestato tutte le sue emozioni, anche attraverso il pianto, ed è mosso dalla compassione, sentimento che prova davanti al lebbroso così come davanti alla vedova di Nain. Castellucci si sofferma infine sul tema della morte, vero e proprio banco di prova degli affetti, presentando tre modi: quella di Socrate e Giulio Cesare, che evocano il sereno distacco tra anima e corpo e l’eroica difesa della dignità rispettivamente, e la morte di Gesù che è intensamente umana, perché porta con sé le ferite e situazioni di tutta l’umanità.
DI ERIO CASTELLUCCI *
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore…?». L’esclamazione dei due discepoli di Emmaus parla del cuore e dell’ardore e questa catechesi è dedicata agli affetti, dimensione umana che però prende le mosse da Gesù. Dice san Paolo: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» (Filippesi 2,5-11). Esortazione che san Paolo fa una ventina di volte nelle sue lettere: esorta i cristiani ad avere dei sentimenti buoni, gli stessi di Gesù. Nella catechesi precedente abbiamo parlato del rapporto con Dio, coinvolgendo anche gli affetti. Questa volta proviamo a puntare sul nostro cuore a partire sempre dagli affetti di Gesù. Ma cuore e affetti non sono il contrario di intelligenza e mente? Gesù in quanto uomo perfetto aveva un’intelligenza, una volontà e aveva anche dei sentimenti.
Gli affetti di Gesù: intelletto, volontà, corpo e cuore
Non vi è dubbio sull’intelligenza di Gesù, che davvero sapeva leggere dentro (Intus-legere). Giovanni lo constata come un fatto, dicendo che Gesù «conosceva quello che c’è nel cuore dell’uomo» (Gv. 2,25). Non si può nemmeno dubitare della Sua eccezionale forza di volontà, che è la seconda caratteristica della nostra vita psichica dopo l’intelligenza. Come dimostrano la Sua tenacia, il Suo coraggio, fino alla preghiera nell’imminenza della propria morte: «Padre, voglio che dove sono io siano anche quelli che tu mi hai dato» (Gv. 17,24). Tutto questo perché l’umanità di Gesù è un’umanità piena. Gesù ha un corpo veramente umano, un’anima veramente umana. E quindi ha tutte le facoltà dell’anima e del corpo: l’intelligenza, la volontà, gli affetti. E però i primi cristiani si sono trovati subito in difficoltà con questa dimensione umana di Gesù, in particolare con il suo corpo. Di solito si pensa che i cristiani dei primi secoli abbiano faticato a credere che Gesù era Dio, ma è proprio vero il contrario: fin dall’inizio fu più messa in discussione l’umanità di Gesù rispetto alla sua divinità. Un Dio che ragiona e che ha intelligenza va bene, ma un Dio che prende corpo e ragiona con la mente umana no. Un insieme di dottrine dei primi secoli dette gnostiche, di probabile origine precristiana, è entrato nella fede cristiana negando l’umanità di Gesù. Tali dottrine attribuivano l’origine del mondo a due divinità differenti: gli spiriti e le anime a un Dio buono e provvidente mentre i corpi e la materia a una divinità malvagia. L’essere umano veniva dunque sezionato in due: la parte nobile era l’anima con le sue facoltà (la mente, la volontà) e la parte cattiva era il corpo con le sue caratteristiche, comprese la sessualità e gli affetti. Platone aveva già sezionato l’essere umano e il mondo in queste due parti, esaltando l’assoluta superiorità della parte spirituale su quella materiale. Gli gnostici sono ancora più radicali: l’essere umano, per loro, è un frammento di divino caduto per punizione in un corpo. Come ci si può salvare allora? Per gli gnostici, attraverso la conoscenza delle dottrine spirituali e un progressivo distacco dalle esigenze materiali, ossia la Gnosis. La versione cristiana dello gnosticismo sezionava la persona di Gesù accettando la sua parte divina, il Verbo, e rifiutando quella umana, la carne. Per loro dire: «Il Verbo si fece carne» (Gv. 1,14) non significava dire che il Verbo si sia veramente mescolato a un corpo, ma che “appare” tale, ossia è un simbolo, una metafora. Dio si è presentato sotto sembianze corporee, sembrava uomo ma in realtà era solo un’apparenza. Questa versione cristiana di gnosticismo prende il nome di docetismo, da dokéin che significa «apparire». Dentro a questa corrente di pensiero c’erano alcuni che sostenevano che il Verbo era sceso in Gesù nel momento del Battesimo di Giovanni nel Giordano e che prima che Gesù venisse crocifisso il Padre lo ha assunto in cielo. Altri sostenevano che ad andare in croce fu Simone di Cirene, che assunse le sembianze di Gesù, il quale è stato prelevato dal Padre. Questa contestazione dell’umano di Gesù, specialmente del suo corpo e dei suoi sentimenti durò fino al IV secolo, quando poi la Chiesa, attraverso i diversi concili fino ad arrivare al Concilio di Calcedonia nel 451, dove stabilirà definitivamente che Gesù è vero Dio e vero uomo.
L’umanità di Gesù
La divinità era dunque meno contestata dell’umanità. La Chiesa dovette difendere la vera umanità di Gesù, fino ad arrivare a dire, come Giovanni nella sua prima lettera che l’anticristo è colui che è uscito da noi (I Gv. 2-19) e aggiunge nella seconda lettera «colui che nega che Gesù è venuto nella carne, quello è l’anticristo» (II Gv. 1,7). Negare la carne di Gesù, negare la sua vera umanità, il suo corpo, i suoi affetti e la densità del suo umano coinvolgimento significa essere l’anticristo, essere contro di Lui. Del resto, i Vangeli mettono in evidenza che Gesù era vero uomo e che cresceva, come dice il Vangelo di Luca: «il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza» (Lc. 2,40). E ancora Luca, quando Gesù viene trovato dodicenne nel tempio: «cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc. 2,52). Cresceva: Gesù non è uno Spirito o un frammento divino incapsulato in un corpo ma è un Dio che si è davvero incarnato, che cresce fisicamente, intellettualmente, spiritualmente e prova emozioni e sentimenti. Le emozioni di Gesù e la sua compassione
La vita affettiva non è facilmente inquadrabile e le scuole di psicologia la classificano in modo molto diverso. Possiamo dire in genere che, quando noi parliamo di affetti, parliamo di quel complesso di facoltà che comprende istinti, passioni, sensazioni, emozioni e sentimenti. Gli evangelisti, senza aver studiato psicologia, attribuiscono a Gesù le quattro emozioni primarie: rabbia, paura, dolore e gioia. Rabbia: quando Gesù scaccia i mercanti dal tempio è preso da turbamento e ira raccontano gli evangelisti. In un’altra occasione, Gesù prova indignazione per la durezza di cuore dei capi del popolo. Sulla paura: basterà citare l’esclamazione: «Ora l’anima mia è turbata; e che dirò: Padre, salvami da quest’ora?» (Gv. 12,27). È Gesù che parla in prossimità del suo arresto. E basta leggere i racconti della passione in tutti e quattro i Vangeli, che non tacciono affatto la paura di Gesù e la sua desolazione interiore. Ad esempio, l’esclamazione di Gesù nell’orto degli ulivi: «La mia anima è triste fino alla morte» (Mc.14,34). E poi c’è il dolore dinanzi alle opposizioni che incontrava tra le persone del suo popolo e per l’esperienza di abbandono da parte di Dio nella croce. Nella Lettera agli Ebrei si legge infatti che Gesù imparò l’obbedienza dalle cose che patì. E infine c’è la gioia, che percorre i Vangeli. Luca scrive che a un certo punto Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse «Ti rendo lode Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai più piccoli» (Mt.11,25). E Giovanni, nel suo Vangelo: «Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa» (Gv.15,9-17). Gesù, infatti è stato un uomo che si è emozionato. Ha percorso tutta la gamma delle emozioni umane. E queste emozioni in qualche modo sono sempre connesse al Padre. La rabbia sorge perché il Padre è mercanteggiato nel tempio. La paura culmina nel timore di essere abbandonato dal Padre. Il dolore Gesù lo soffre perché rimane fedele al Padre, anche quando gli amici lo abbandonano e quando i nemici lo insultano e lo uccidono. E la gioia nasce dalla constatazione che il Padre predilige i piccoli rispetto ai sapienti di questo mondo. Gesù, dunque, è stato completo nelle emozioni, fino al pianto. Ma c’è un sentimento che domina su tutti: la compassione. Gesù prova questo sentimento davanti al lebbroso, davanti alla folla che gli appare come gregge di pecore senza pastore e davanti alla morte del figlio unico della vedova di Nain (Lc. 7,11-17). In questi tre casi gli evangelisti usano un verbo affettivamente molto carico, il più denso dal punto di vista dei sentimenti: splanchnízomai. Un verbo quasi impronunciabile, che contiene la parola splanchna, che richiama le viscere o il grembo. Si potrebbe forse tradurre questo verbo con una locuzione: si mossero le viscere, si agitò il grembo. Come si capisce, è un verbo che richiama anche la maternità. E Gesù attribuisce anche al Padre questa intensa affettività. Una delle parabole più belle dei Vangeli è certamente quella del Padre misericordioso: un Padre che ha sentimenti materni. Quando il figlio lontano ritorna, lui, che lo aspettava, commosso gli corse incontro. Quel commosso traduce appunto il verbo splanchnízomai. Si muovono le viscere di questo padre, quasi si muove il grembo. È un padre materno: il figlio ritorna e per lui è come se lo generasse. Questo eccesso di misericordia non contraddice il giudizio. La misericordia del Padre non è una cancellazione superficiale della colpa, bensì un accogliere di nuovo la vita del figlio nel suo grembo, come una madre. È bella la rappresentazione che ne dà il pittore Rembrandt nel 1668, illustrando proprio questa scena del ritorno del figlio: il particolare delle due mani che abbracciano il figlio, di cui la mano sinistra è maschile e quella destra è femminile, volendo dire che il figlio è accolto dal padre e dalla madre insieme. Dio è giudice misericordioso e Gesù ci svela gli affetti stessi del Padre. Lui è, in un certo modo, il cuore del Padre che pulsa sulla terra, tra gli uomini.
I nostri affetti
Plasmati sul modello di Gesù, anche noi siamo corporei e viviamo di legami affettivi. Il corpo non è un appesantimento dell’anima ma segna un limite, perché ci lega un tempo, a uno spazio. Il corpo dunque è limite, ma è soprattutto legame: porta le ferite affettive a cui tutti siamo in qualche modo legati e da cui tutti siamo segnati. Talvolta si attribuisce alla famiglia di origine la responsabilità perché la nostra affettività non è perfetta: è vero non esiste una famiglia totalmente a posto, nessuno di noi ha ricevuto un’educazione così armoniosa ed equilibrata da non presentare delle crepe ma è segno di maturità accettare di vivere con queste ferite, proprio perché il nostro corpo è legame. Noi non veniamo direttamente dal cielo ma passiamo attraverso genitori umani, relazioni umane, condizionamenti umani. Se fossimo solo anime certamente non saremmo così feriti, ma non saremmo neppure così appassionati; non vivremmo gli affetti con così tanta profondità. Siamo corporei proprio per poterci legare, per poter amare. Siamo voluti da Dio maschio e femmina perché complementari e reciproci, perché nessuno di noi pensi di essere completo da solo. Tutti siamo chiamati a uscire da noi stessi e ad amare: sia chi sceglie la vita di coppia e il matrimonio sia chi sceglie la verginità o il celibato. Tutti siamo chiamati a legarci a Dio e agli altri secondo lo stile del dono. Papa Benedetto XVI, nella sua prima enciclica, illustra chiaramente il senso del corpo, il suo rapporto con l’anima e la vocazione di ogni essere umano ad amare (Deus Caritas est, n.5). Il corpo e l’anima segnano tutte le nostre relazioni: con Dio, con sé stessi, con gli altri, con il mondo. Ne parleremo più dettagliatamente nella nostra catechesi, ma già ora vorrei mettere in evidenza, con l’aiuto di una famosa pagina di Alessandro Manzoni, del quale si ricordano i 150 anni dalla morte, come sia proprio la compassione, intesa in evangelico, a fare la differenza nei nostri legami, anche nel legame con Dio. È provando compassione per Lucia che l’Innominato ritrova Dio. Nel racconto: Lucia, rapita dai bravi dell’innominato, viene portata al castello e il Nibbio, potremmo dire il capo dei bravi relaziona al suo padrone quello che era successo. E lo fa parlando di compassione (I promessi sposi, 1840. Cap. XXI). Non è mai solo questione di ragionamento e di volontà. Ma è sempre anche questione di affetti. Ci convertiamo a Dio, al Dio di Gesù Cristo, che non è mai un freddo calcolatore, un motore immobile, un principio astratto, quando ci lasciamo raggiungere anche il cuore e non solo il cervello.
Una morte umana, manifestazione ultima degli affetti
Uno dei banchi di prova degli affetti è la relazione con la propria morte, specialmente quando si presenta come evento prossimo. Davanti alla propria fine imminente uno non può barare, ma emerge tutta la gamma degli affetti: istinti, passioni, emozioni, sentimenti. E allora vorrei chiudere questa catechesi illustrando brevemente tre modi di morire, che sono diventati dei paradigmi, dei modelli, e che ci possono aiutare a capire ancora meglio l’importanza degli affetti per noi cristiani. Il primo è la morte di Socrate, nel 399 a.C.: nel dipinto di Jacques-Louis David, nel 1787, la scena è rappresentata secondo la descrizione che ne dà Platone nel Fedone (116e – 118a). Socrate ha preso la cicuta, i discepoli si disperano ma Socrate è sereno. Platone insiste sul fatto che Socrate affronta la morte serenamente: è in effetti convinto che lo attende un’eternità beata o comunque una situazione migliore della vita terrena; è circondato da una corona di discepoli afflitti. Una morte senza turbamenti: questo era il grande ideale dei sapienti greci, che poi gli stoici, una corrente che avrà molta fortuna anche a Roma teorizzerà parlando di una necessità di essere indifferenti di fronte a tutte le emozioni e turbamenti della vita, compresa la morte, e arriveranno a dire che è necessario togliersi la vita quando si rischia di trovarsi in una situazione non totalmente degna. Meglio morire e preservare la propria dignità che vivere travolti dalle passioni o finiti nelle mani altrui. La morte è affrontata e vinta con le forze della ragione e della volontà. Il secondo esempio è la morte di Giulio Cesare, nel 40 a.C., rappresentata in un dipinto di Vincenzo Camuccini del 1806: una scena molto violenta, molto più mossa rispetto alla morte di Socrate perché avviene come assassinio. Giulio Cesare non è impreparato di fronte alla possibilità di essere assassinato e lui reagisce eroicamente, muore con decoro. Se Socrate aveva affrontato la morte da eroe sapiente, Cesare l’affronta da eroe combattente e coraggioso, come racconta lo storico romano Svetonio, inVite dei dodici Cesari, Vita di Giulio Cesare, 82. C’è però un terzo esempio, che sembra sfigurare rispetto a quelli precedenti, ed è proprio l’esempio della morte di Gesù. La crocifissione rappresentata nel dipinto di Matthias Grünewald (1512-1516) è una rappresentazione impressionante. Se la si contempla per qualche secondo rende l’idea di questa morte di croce, che era considerata dagli Ebrei non una pena di morte tra le altre ma la morte dei maledetti da Dio. E infatti i Vangeli ce la descrivono con tutta la tragicità che porta in sé, come ad esempio l’evangelista Marco (15,2937). Il versetto di Paolo, che ho citato all’inizio «abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» (Filippesi 2,5) ci spiega poi quali sono questi sentimenti, tirando fuori una realtà che non ha niente di attraente. Potremmo dire che è agli antipodi di una realtà sentimentalmente interessante perché c’è questa descrizione ben nota. «Egli pur essendo nella condizione di Dio non ritenne un privilegio l’essere come Dio». Cioè, descrive proprio la morte di croce. La lettera di san Paolo ai Filippesi (2,5-11) offre accenti ben diversi rispetto a Socrate e Giulio Cesare. Gesù non muore da eroe, ma da uomo. Socrate e Cesare dovevano fare i conti solo con la loro anima mentre Gesù porta con sé tutte le situazioni umane. Il suo corpo ferito e crocifisso convoglia tutti i corpi feriti del mondo. Egli raggiunge il punto più basso, come ci ha detto san Paolo, la morte di croce. Perciò la sua morte non è affatto serena né eroica ma affettivamente carica, perché porta su di sé le situazioni altrui. Quando viviamo un disagio affettivo, una qualsiasi croce, per rimetterci a posto non basta guardarsi dentro, ma aprirsi, relazionare la propria vita con quella degli altri. Questo ha fatto Gesù sulla croce. Quando i discepoli di Emmaus sentono «ardere» i loro cuori non rimangono in casa, ma tornano a Gerusalemme. La nostra vita affettiva, con tutte le sue ferite, va continuamente risistemata donandoci, non chiudendoci; cercando le relazioni giuste, non chiudendo ogni rapporto.
*arcivescovo
“Non ardeva forse in noi il nostro cuore?” – LA DIMENSIONE AFFETTIVA – 6 novembre 2023:
- Catechesi dell’Arcivescovo Erio Castellucci
- Domande per la riflessione
- Video YouTube
- Approfondimento dell’ufficio famiglia: “Per chi, per cosa arde il loro cuore… e il nostro?” Incontro con il dott. Alberto Pellai, medico, psicologo psicoterapeuta – 25/11/2023
- Approfondimento del Servizio di Pastorale Giovanile: “Il dono del corpo riguarda la persona” Incontro con suor Roberta Vinerba – 25/11/2023
- Approfondimento dell’Arcivescovo Erio Castellucci: “L’eternità, un orizzonte che dona senso alla vita” – 25/11/2023